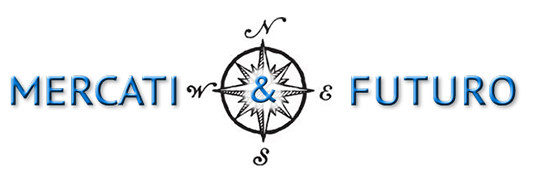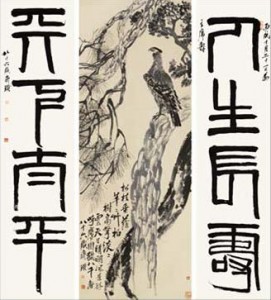Arte e antiquariato, investimenti alternativi?
Possibile affrontare con successo il mercato dell’arte ed antiquariato, anche non essendo grandi investitori? Sì, secondo l’esperta Cristiana Curti, con l’ulteriore vantaggio che “nessuna agenzia di rating potrà mai declassare il nostro investimento”.
Come promesso nei giorni scorsi, cominciamo a spaziare oltre gli abituali temi del blog, per approfondire altri mercati e altre categorie di beni rifugio. Pubblichiamo un primo contributo sugli investimenti nel mercato dell’arte ed antiquariato a firma di Cristiana Curti, esperta collezionista che ci onora della Sua collaborazione dedicando la propria esperienza ai nostri clienti ed ai lettori del blog.
Gli interessati a pareri, consulenze, previsioni in materia, possono contattare:
mg@mercatiefuturo.com
2012. UN NUOVO MERCATO DELL’ARTE (?)
di Cristiana Curti
Ho tentennato nell’approntare l’incipit di questa nuova rubrica per il blog “Mercati e Futuro” curato dall’amico Mario Galli, che mi onora con una richiesta auspicabilmente foriera di nuove opportunità per tutti. Esiste nei fatti una crescente difficoltà per chi, come me, si occupa – da collezionista, osservatrice-analista e consulente – di mercato dell’arte da diverso tempo e si cimenta nel tentativo di spiegare con semplicità le caratteristiche salienti di questo singolare comparto.
Cercherò di non soffermarmi oltremodo intorno a ciò che tutti invece notano come il fenomeno primario di questo settore: quello dei records eclatanti e apparentemente fuori di senso e misura che infiorettano le cronache e solleticano la pruderie delle anime belle. Anch’essi hanno le loro motivatissime giustificazioni che, se correttamente considerate, fanno comprendere come un oggetto d’arte possa divenire un bene di scambio per eccellenza, anzi per antonomasia, a patto di spogliarsi della sua artisticità “fenomenica”, sublimata in un’essenza più intrinseca di “bene di lusso”, inteso come ciò che – data la sua rarità – è di talmente difficile quantificazione da costringere, mediante continui tentativi, a trovare un limite che poi si tenderà ancora a superare.
Per chi non è aduso alla frequentazione del settore “merceologico” dell’arte, ma conosce le regole del mercato finanziario e borsistico, il mio approccio poco ortodosso parrà forse un azzardo. Ma a me pare sia l’unico possibile per chi, senza particolari apparati informativi pregressi e consulenze d’altissimo cabotaggio (che di sicuro diluiscono la possibilità di “errore” ma di certo diluiscono anche la personalità e l’autonomia operativa del compratore), voglia intraprendere una strada che porterà spesso a dimenticare se stessa, in virtù di una crescente passione che potrebbe, se priva di regole, prevaricare il senso dell’opportunità.
Ma, per questo motivo, e contrariamente a come si dovrebbe affrontare ogni altro comparto che si occupi di investimenti, è proprio questa la dimensione giusta per accostarsi al mercato dell’arte. Ed è anche questa capacità di commisurare passione e cultura con intelligenza e sagacia che permette (senza “particolari apparati informativi pregressi”…) di inquadrare le temporanee perplessità all’interno di un panorama di più ampio spettro, in una prospettiva che apre a scenari d’azione (quasi) sempre imprevedibili.
Se coloro che sono abituati al forex e allo scambio ardito sui listini di borsa di mezzo mondo agiscono secondo diagrammi in evoluzione pressoché lineare anche se discontinua, coloro che acquistano arte seguono piuttosto una corsa spezzata con scarti laterali e retrocessioni, per cui non esiste un vero e proprio traguardo (perché è un tragitto che si arricchisce e diventa più complesso durante il percorso) e, men che meno, un risultato immediatamente percepibile.
Questa caracollata anomala è più simile al procedere del gioco del domino. Non c’è dubbio, fra l’altro, e sarebbe un terribile errore (questo sì) ritenere il contrario, che questa caracollata che coinvolge il nostro portafoglio non sia di carattere squisitamente (quanto solidamente) “difensivo”. Potremo dire, rimanendo nelle metafore suggestive, che trattasi di un percorso “indiano” che spiazza il nemico inseguitore attraverso efficaci e risolutivi depistaggi.
Complice l’aumentata complessità degli strumenti d’investimento e il velocemente mutato quadro socio-politico globale, si tende sempre più a raffrontare il mercato dell’arte con quello finanziario e a cercare di leggerne in entrambi le assonanze o le parziali adesioni, in un parallelismo che a me, in realtà, pare solo di facciata.
E se è vero che – astrattamente – in momenti di crisi ci si affanna alla ricerca di “beni rifugio” che possano differenziare e tutelare il nostro portafoglio, il mercato dell’arte (da sempre considerato appannaggio di una borghesia ricca e prudente oggi in progressiva dismissione) è quanto di meno assimilabile con il mero trasferimento di “quote di materia finanziaria” (valuta, titoli, ecc.) da una tasca all’altra. Non c’è niente di più indipendente (crisi epocale o floridume sociale) nei suoi scarti indicativi dell’analisi delle quotazioni di Fontana o del Borgognone.
L’aumento di enormi masse di liquidità, sbloccate anni fa con il crollo dei Paesi del blocco sovietico e in seguito, tutto sommato a breve ruota, dai cosiddetti “mercati emergenti” d’India e Cina, ha certo determinato, nel volgere del millennio, il moltiplicarsi frenetico dei risultati strabilianti per lotti che prendevano la strada di paesaggi diversi dalle roride campagne inglesi, dai raffinati penthouses newyorkesi o dagli ubertosi palmizii degli Emirates.
Ed è altresì vero che la crisi globale ha portato ad affinare gli strumenti, a scremare le fasce intermedie di acquisto (quelle dove oggi è, invece, più semplice avere ottimi risultati, se si ha la pazienza e la volontà di cercare) sempre più indebolite da una effettiva crisi di offerta (è assai più difficile trovare opere interessanti da proporre che, trovate, venderle) dovuta al timore di un innegabile deprezzamento delle opere minori di qualsiasi settore si tratti, dall’antiquariato, all’arte antica, alla fotografia, all’arte moderna e contemporanea soprattutto, quella ancora non storicizzata e non provvista di pedigrees istituzionali sufficienti a metterla al riparo dalle avversità della critica militante.
I diversi reports relativi al 2011 in merito alle quotazioni e agli scambi del mercato artistico mondiale raccontano tutti, senza eccezioni, di un progressivo dissolvimento di questa cosiddetta fascia media di transazioni, quella che per decenni ha costituito la base su cui il mercato intero si è costruito solidamente.
Si favoleggia solo dei top-lots e di come, “malgrado la crisi”, il trend al rialzo dei nomi più noti sia costante, i records sempre pronti a superare se stessi, le nuove (anche se ormai nuove non sono più) piazze di Cina, India, Russia a stupire con il volume impressionante degli scambi, tanto che le maggiori case d’Asta come Christie’s e Sotheby’s puntano velocemente verso questi ricchi lidi anche promuovendo lo sviluppo dell’arte locale, nel contempo alleggerendo di pesanti e costosi apparati di servizio la rete commerciale della vecchia Europa.
Le nuove sedi, in particolare cinesi e in particolare sulla piazza già storica e rodata di Hong Kong (nella Repubblica Popolare propriamente detta non sono ancora in vigore licenze di vendita d’arte nazionale da parte di Società straniere), sono lussuose quanto mai in madrepatria furono: acquartierate in palazzi sontuosi, spesso allestiti all’occorrenza per speciali evenienze, sono provviste di decine di addetti, titolatissimi esperti, tutti indigeni e con pochissimi tutors occidentali, e molteplici servizi dedicati al facoltoso cliente. I risultati non si sono fatti attendere. In una manciata di aste, solo l’autunno passato, Sotheby’s e Christie’s hanno totalizzato oltre 858 milioni di dollari, ma sono state raggiunte e superate dalle già agguerrite case d’asta cinesi (di cui le maggiori sono Poly Auction House, A&F, Guardian e Council, tutte ubicate nella capitale) che con un fatturato complessivo sul territorio di oltre un miliardo e mezzo di dollari determinano un indotto “territoriale” per il mercato dell’arte di ca. 2,4 miliardi di dollari, ovvero ben più del giro d’affari globale di Christie’s nel 2009, anno – per la verità – non proprio “caldissimo” per le case d’asta occidentali.
Del resto, già dal 2009, ben nove delle venti maggiori case d’asta mondiali sono cinesi e, di queste, quattro (alcuni osservatori dicono anche di più: le notizie dei bilanci delle Società, tutte a partecipazione statale, non sono del tutto trasparenti) sono fra le prime dieci.
Per quanto riguarda poi il singolo risultato eclatante, nel 2011 i top-sellers mondiali del mercato dell’arte visiva hanno perso la pole-position, per anni saldamente occupata da Picasso e Warhol, per cedere il passo agli artisti cinesi “padri” della scoppiettante arte contemporanea nazionale. Nomi a noi del tutto sconosciuti come Xu Beihong, artista della prima metà del XX secolo, facitore di suggestivi acquerelli che ricalcano gli stilemi dell’arte tradizionale Zen risolta modernamente con l’adozione della prospettiva occidentale e di maestosi oli di argomento epicamente rivoluzionario, strappano quotazioni fino a pochissimi anni fa impensabili (anche se, in realtà, prevedibili per l’attenzione maniacale e ossessiva per la quale il collezionismo d’arte cinese aveva sviluppato un mercato “interno” sin dagli anni ’60-‘70 del secolo scorso): una sua sognante gouache a inchiostri del 1951 ha raggiunto lo scorso dicembre la cifra di 42 milioni di dollari. E un importante dipinto del quasi coevo Qi Baishi, Long Life, Peaceful World, a maggio 2011 ha fermato il martelletto a 65,5 milioni di dollari, ciò che rappresenta il record annuale in asta per oggetti d’arte cinese. Del resto, questo per noi sconosciuto artista era ammirato dallo stesso Picasso, che lo considerava il maggior pittore asiatico del XX secolo.
Definitivamente, nel 2011, l’arte cinese (antica, moderna e contemporanea) supera, per volume d’affari e risultati superiori alle stime, quella di qualsiasi altro Paese occidentale. E ciò proprio allorquando, per la prima volta dopo anni di corsa spensierata, il PIL della Cina segna il passo attestandosi in una percentuale inferiore alle due cifre, benché certo ancora sostenuta.
I collezionisti d’arte cinese, tuttavia, non acquistano soltanto nelle piazze asiatiche, ma sono pronti a saccheggiare (letteralmente) le occasioni sempre più frequenti che il mercato europeo e statunitense ha subito approntato al cambiar di bandiera.
Persino a Milano, le raffinate giade d’Oriente riescono a salvare, nell’ottobre 2010, un’asta di Old Masters da Sotheby’s altrimenti disastrosa per come la sorte si era dichiarata avversa (ai venditori). Era in dispersione la nota collezione Alemagna di arte antica, che annoverava nomi come Guardi, Tiepolo, Zais, Zuccarelli, Solimena e molti altri. I lotti più notevoli, due magnifici Canaletto, provenienti dall’inglese raccolta Spencer, venivano dal solerte funzionario statale arbitrariamente accoppiati (non “nascevano” in ensemble), notificati in corso d’esposizione e rimanevano così invenduti. E mentre lo spettro della pre-notifica (ingiusta scure delle Soprintendenze che si abbatte in corso di una lecita vendita, qui sciabolata subito prima dell’aggiudicazione sul Guardi, rimasto anch’esso inesitato) si aggirava terrifica per altri nomi importanti dell’incanto, la collezione di giade cinesi della nota famiglia milanese dei panettoni risolleva letteralmente la situazione con il 100% di venduto e la quasi decuplicazione delle stime. Record: una guanyin (divinità della tolleranza e della compassione) in giadeite che il “mastro cerimoniere” Philippe Delalande aveva sin troppo cautamente stimato 4./6.000 euro e che, fra lo sbigottimento generale della sala, aveva raggiunto la bella cifra di 366.750 euro compresi i diritti.
Nel contempo, proprio nel 2011 le maggiori case d’asta riducono all’osso i comparti di vendita in Europa e in Italia. A Milano, Sotheby’s chiude i dipartimenti di antiquariato e arte antica e lascia solo quelli di arte moderna e contemporanea. Finarte, storica casa d’incanto italiana della ricca e colta borghesia prima milanese e poi nazionale, non resiste al mutare dei tempi che impongono strutture agili e sempre più ricorso al web (a cui rimane incomprensibilmente ostile per tutto il corso della non brillante gestione Corbelli) e affonda la sua storia gloriosa dopo un’agonia penosissima. A Venezia, la casa d’aste San Marco (capitanata da Marco Semenzato, dell’omonima casa d’incanti già chiusa anni prima) finisce alla fine del 2010 la sua corsa nei lacciuoli del fallimento, con un “bel” buco di quindici milioni di euro e trecento creditori alle porte.
Ma è solo, per l’Italia, un fenomeno evolutivo da osservare con attenzione per vederne i contorni differenti dalle considerazioni di superficie tendenti al facile (e per alcuni assai proficuo) catastrofismo.
Mentre si riconvertono le grandi industrie dell’arte (anche aumentando il volume delle private sales, delle vendite a trattativa privata, particolarmente adeguate per il compratore d’Occidente, ora più attento alle occasioni e agli invenduti e spesso poco incline all’eccessiva esposizione mediatica) con un riverbero che travolge anche molte gallerie occidentali, stremate dalla contingenza e, per l’Italia, da un coacervo di leggi che penalizza il mercato come non accade in alcun altro Paese al mondo, altre realtà meno appariscenti ma altrettanto appetibili per il compratore cominciano già a raccogliere i primi frutti di un lavoro serio, capillare e poco propenso a prestare orecchio all’ hic et nunc cui le “sorelle maggiori” devono giocoforza sottostare.
In Italia emergono finalmente nel corso del 2011 le realtà commerciali che più si sono fatte valere negli anni precedenti con mezzi agili e semplici, con apparati poco dispendiosi e una capillare conoscenza del territorio e del nostro straordinario “bacino di opzioni”: la ricca e importante dimensione qualitativa dell’arte e dell’antiquariato delle nostre Regioni, dopo un periodo di tranquillità forzata, fa nuovamente capolino con insistenza e motivati meriti.
Valga qui ricordare che, dopo quello francese (alcuni direbbero “prima”), il mobilier più raffinato e prezioso al mondo è senz’altro appannaggio del vasto puzzle delle realtà locali italiane. Se nel XVIII secolo Parigi aveva i suoi menuisiers (falegnami) ed ébénistes (ebanisti) rigorosamente assoldati (e tutelati) alla corte di Versailles, in Italia, Torino e il Piemonte, Milano e la Lombardia, Genova e la Liguria, Venezia con la sua amplissima ramificazione di scuole artistiche e artigiane che vanno da Brescia a Verona a Trento, ma anche Parma, Modena, Lucca, Napoli e Palermo, riflettevano la copiosa espressione delle nostre eccellenze e diffondevano il senso di un gusto estremo e senza rivali.
E così dicasi per l’arte antica e moderna, benché quest’ultima sia oggi succube dell’improvvido protezionismo invocato dal legislatore e dal burocrate a condanna del nostro straordinario ‘900. Con l’esercizio di notifica, vincolo o tutela (ex art. 1089/1939 e successive modifiche), lo Stato attraverso le Soprintendenze impone la necessità di un controllo diretto (e illimitato) a propria discrezione per opere di artisti importanti eseguite oltre cinquant’anni a far corso dal tempo presente (ossia, nel 2012, ante quem 1961) privandole di fatto della possibilità di passare di mano (vietata del tutto fuor di confine), ancorandola alla registrazione ufficiale della proprietà e a una serie di vincoli che ne sconsigliano vivamente il possesso a patto di poter subire senza contraccolpi certe imposizioni. Per tutti, l’obbligo di garantire, al momento della vendita, la prelazione all’acquisto da parte dello Stato, opzione che quasi mai si perfeziona e che, da sola, determina la riduzione drastica del numero degli acquirenti e, va da sé, del prezzo di vendita che si inabissa ben sotto le quote di mercato relative a quel soggetto artistico.
Esempio cardine di questa ingiustizia legalizzata è ancora quello fornito dalla storica vendita (1992) della Collezione Jucker di arte moderna (40 opere dei più grandi artisti europei e italiani del primo ‘900, notificate in blocco e quindi – per di più – inseparabili) al Comune di Milano dopo estenuanti trattative. Il prezzo stabilito fu di 47 miliardi da versarsi agli eredi in sette anni.
Valgano su tutte le banali considerazioni che a) la sola tela di Picasso, La Femme nue del 1907, aveva ricevuto un’offerta di molti miliardi di lire dalla Fondazione parigina dell’artista spagnolo, b) la Fondazione Guggenheim avrebbe rilevato l’intero gruppo partendo da una base due volte superiore alla cifra poi concessa dal Comune e c) oggi, a soli vent’anni di distanza, quei quaranta magnifici capolavori varrebbero oltre 200 milioni di euro secondo una stima non imprudente e aderente al mercato attuale.
Le nostre scellerate leggi contrarie alla circolazione delle opere d’arte di rilievo (anche non nazionali, se parte di una collezione organicamente concepita) hanno già cancellato dalle grandi aste (in particolare dalle Italian Sales organizzate da circa un paio di lustri da Sotheby’s e Christie’s a Londra due volte l’anno) i grandi nomi italiani del primo Novecento – che a fatica avevano ben seminato nel corso degli ultimi trenta anni, con mostre di caratura e lo sforzo titanico di pochi agguerriti musei e caparbi studiosi italiani – e presto arriveranno a comprimere quelli del secondo. Lo scenario è fosco, anche se è probabile una benefica inversione di rotta da parte del legislatore europeo che già richiede una maggiore tolleranza in merito alle italiche transazioni. Tuttavia, al momento, i danni già registrati sono notevoli.
Eppure, malgrado questi impervi ostacoli, la ricchezza dell’offerta appannaggio del genio italico vince anche queste riserve e permette di ben sperare per il futuro, perché, laddove la qualità è suprema, è possibile reperirne lacerti, anche sostanziosi, nel “piccolo”, ovvero in quella malcapitata fascia media che oggi sembra subire le avversità del periodo recessivo, ma che invece si prepara per una fase di giusta riscossa.
Questa è degnamente supportata da Società che hanno con il tempo guadagnato il palcoscenico nazionale e che certamente promuoveranno una certa ripresa degli scambi in genere, favorendo anche in parte la rivivificazione delle gallerie d’arte, da qualche anno a questa parte in ambasce progressive.
Mi riferisco alle ottime realtà delle case d’asta “locali” quali, fra le altre, il Babuino e l’Antonina a Roma; Blindarte a Napoli; Bolaffi e Sant’Agostino a Torino; Cambi, San Giorgio e Wannenes a Genova; Pananti e Pandolfini a Firenze; Farsetti a Prato, Milano e Cortina; Stadion a Trieste; Van Morenberg a Trento; Il Ponte, Poleschi, Pace, Porro Art Consulting (capitanata da Casimiro Porro con buona parte dell’ex staff Finarte pre-Corbelli), International Art Sale a Milano; Meeting Art a Vercelli (dal 2011 diventata la prima casa d’aste italiana per fatturato e volume d’affari).
Queste vivacissime e dinamiche società spesso si avvalgono di notevoli esperti e studiosi blasonati e trattano oggetti “consueti”, oltre all’arte figurativa, per il pubblico italiano provinciale (nel senso dell’eccellenza della provincia, non in quello deteriore dell’accezione): quali gli argenti, i tappeti, i mobili, le ceramiche, i vetri, le lacche, il design del Novecento, i memorabilia, i vini, ecc. ecc. Alcune sono specializzate in mercati solo apparentemente di nicchia ma che invece stanno muovendosi con estrema accortezza e solidi scambi, come il settore della fotografia e quello di gioielli e orologi.
A ben osservare, c’è una enorme possibilità di costruire collezioni di caratura per l’intelligenza degli investimenti e interessanti per l’intrinseco valore culturale in non molto tempo con la nostra arte di qualità, ma non ancora sotto i riflettori del mercato e delle sue bolle, avendo l’accortezza di ben scegliere e verificare con cura ogni opzione.
Ritengo che l’acquirente italiano che volesse tutelare una parte del proprio portafoglio in investimenti a basso rischio potrebbe essere invogliato (e ben diretto) all’acquisto di oggetti di antiquariato (oggi particolarmente pronto al buon affare, soprattutto se non in fascia altissima) e d’arte antica (la più prolifica di sorprese e garanzie) moderna e contemporanea (che subisce più di tutte la stanchezza di una eccessiva produzione senza la prova dell’incanto). Segnalo anche, in sempre maggior crescita e foriero di evidenti sviluppi positivi, il comparto dei preziosi e degli orologi per il quale però è necessaria una perizia certificata e la tutela di un suggeritore che deve essere al di sopra di ogni sospetto.
Il 2012 è anno di rivolgimenti epocali nella finanza e nell’industria. L’arte starà a guardare… ma non si lascerà facilmente dominare dai capricci dei subprimes e di coloro che li combattono. Diventerà sempre più una delle scelte privilegiate dagli investitori prudenti e procederà solo raramente in corse senza costrutto verso una probabile bolla che scoppierà, però, e forse, solo per determinati azzardi, già verosimilmente in bilico.
Come in pochi settori d’investimento, qui è d’obbligo la profonda meditazione su ciò che si sta facendo e la volontà di costruire, oltre che di spendere. Il risultato è di enorme soddisfazione – da sempre – per chi avrà saputo supportare, con i propri acquisti oculati, la nostra Arte, la nostra Cultura e la nostra Storia. Che, me lo si lasci dire, nessuna agenzia di rating – davvero – potrà mai declassare.
Cristiana Curti
Per contattare l’autrice potete scrivere a:
mg@mercatiefuturo